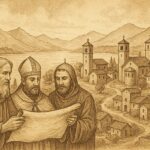Ogni luogo ha la sua voce, ma quella del Lago di Como è unica: antica, musicale, intrisa di memoria. È una lingua fatta di parole che non si trovano nei dizionari, nate dall’acqua e dalle montagne, modellate dal vento e dal lavoro quotidiano. Un dialetto che cambia da borgo a borgo, da riva a riva, ma che conserva ovunque lo stesso ritmo lento, la stessa cadenza dolce e ferma di chi vive ascoltando la natura.
Tra Gravedona, Domaso e Sorico, il linguaggio non è solo uno strumento: è un modo di appartenere. Ogni parola porta con sé un gesto, un’abitudine, un frammento di vita. “Larii”, “làa”, “breva”, “ciüf” — termini che sfuggono alla traduzione e che, come le onde del lago, cambiano forma ma non sostanza. Molti anziani ancora oggi parlano “cumè ‘na volta”, e chi li ascolta si accorge che tra una frase e l’altra non si trasmette solo un suono, ma un’intera visione del mondo.
Un tempo, il dialetto era la lingua di tutti. Si parlava nei cortili, sulle barche, nelle botteghe. Era la lingua delle donne che impastavano il pane e degli uomini che costruivano muri a secco, dei pescatori che si chiamavano da una riva all’altra. Ogni mestiere aveva il suo vocabolario: i contadini distinguevano venti tipi di erba e dieci di pioggia; i barcaioli sapevano nominare ogni corrente del lago. La lingua era precisa, concreta, fatta per descrivere la vita quotidiana senza bisogno di troppe parole.
Poi, con il tempo, è arrivato l’italiano delle scuole, delle città e della televisione. Molte parole si sono perse, altre sono sopravvissute solo come espressioni affettuose o scherzose. Ma sull’Alto Lago, più che altrove, il dialetto non è mai davvero scomparso. Resiste nei saluti — “ciao, sciur!”, “bun di”, “tö sü” — nelle frasi dette a metà, nei proverbi che i nonni ripetono ancora, spesso sorridendo.
“L’è mej un bon ves che cent paroll”, dice un detto di Domaso: meglio un buon bicchiere di vino che cento parole. Oppure “El temp l’è ‘na spada”: il tempo è una lama, taglia ciò che non serve. Frasi brevi, essenziali, che condensano la filosofia di un popolo abituato a vivere tra la fatica e la bellezza.
Ogni borgo del lago custodisce variazioni sottili. A Gravedona le parole hanno una cadenza morbida, quasi cantata; a Sorico diventano più secche e montane, influenzate dai suoni della Valtellina; a Dongo si mescolano con termini del Comasco e del Ticinese. Chi è cresciuto qui sa riconoscere la provenienza di una persona dal modo in cui pronuncia una vocale o accorcia una parola. È un codice invisibile, ma profondamente identitario.
Ci sono parole che raccontano la geografia stessa del lago. “Brevéta” indica il vento leggero del pomeriggio, “riva” non è solo la sponda ma anche la casa, il luogo dove si torna. “Lüna” è la luna che si specchia nell’acqua, ma anche un modo per dire malinconia. “Larii” era il nome degli antichi abitanti del lago, e in qualche modo lo è ancora: chi nasce qui porta dentro di sé quella radice.
Oggi il dialetto vive una nuova stagione. Molti giovani lo riscoprono, lo studiano, lo usano per scrivere poesie o canzoni. Le scuole organizzano laboratori linguistici, le biblioteche raccolgono testimonianze orali, i festival locali dedicano spazi alle parlate tradizionali. È un ritorno consapevole, non nostalgico: la volontà di mantenere viva una lingua che racconta più di qualunque libro il carattere di un territorio.
Anche la musica ha avuto un ruolo importante in questa rinascita. Alcuni gruppi dell’Alto Lago hanno iniziato a inserire versi dialettali nei loro brani, fondendo sonorità moderne con parole antiche. È un modo per rendere il dialetto contemporaneo, per farlo respirare nel presente senza snaturarlo. E quando una parola in dialetto si infila tra le note, succede qualcosa di raro: il lago sembra parlare di nuovo, con la sua voce autentica.
Camminando per i vicoli di Vercana o lungo le rive di Gera Lario, capita ancora di sentire una conversazione che sembra arrivare da un’altra epoca. Due anziani che discutono del tempo, una donna che richiama il cane, un gruppo che ride davanti a un bar: poche frasi, ma dense di vita. In quelle parole c’è tutto — il senso dell’appartenenza, la lentezza, la gentilezza ruvida della gente del lago.
Il dialetto del Lario non è solo un ricordo, è una forma di resistenza culturale. È la memoria parlata di un mondo che cambia, ma che non ha smesso di avere radici. In un’epoca in cui si comunica con messaggi brevi e traduzioni automatiche, questa lingua rimane un gesto di libertà, un modo per dire: noi siamo ancora qui, con le nostre parole, con la nostra storia.
E così, quando il vento del Tivano soffia tra le case e le montagne si riflettono nel lago, sembra di sentire la lingua del Lario risvegliarsi ancora una volta. Non nei libri, ma nelle voci che si intrecciano tra un buongiorno e un proverbio, tra un ricordo e una risata. Perché ogni parola, se nasce vicino all’acqua, trova sempre un modo per tornare a galla.